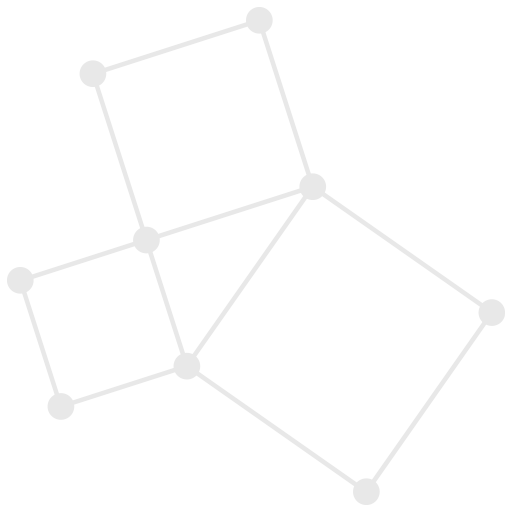La via del pane
Il sogno, una visione
Per un artista è molto difficile spiegare come l’opera prende forma tra idea, progetto e ispirazione, molti per dissimulare questa difficoltà si avventurano in pericolose arrampicate su specchi infidi, spacciando per vere teorie pretestuose e racconti inattendibili.
D’altro canto un’opera è un evento e il suo realizzarsi spesso somiglia a una magia, qualcosa che avviene in sogno. L’ispirazione infatti, di per sé somiglia ad una visione, cui l’artista sente la necessità di dare corpo fisico. Ognuno con il suo stile e secondo le proprie capacità; io sono uno scultore e so bene quanto sia difficile dare conto del passaggio dall’idea alla forma e quanta fatica, anche fisica richieda, quanta perizia… non ci sono formule o parole per esprimere questa trasmutazione da immagine a cosa, soltanto un poeta potrebbe riuscirci. Anche se di fatto non è necessario perché credo che la potenza dell’arte consista proprio nel rendere accessibile a tutti attraverso l’intuizione la forza simbolica di cose, le quali, per il solo fatto di esserci, acquistano un senso ulteriore come il possibile manifestarsi di una verità.
Nel caso specifico de “La Via del Pane”, ad esempio, nel dormiveglia ho avuto la visione prolungata di una scena durata un lunghissimo istante, una specie di allucinazione soffusa, di quelle che ci colgono quando stiamo per addormentarci sospesi tra la veglia ed il sonno. Come questa visione sia diventata un’opera è difficile da spiegare. Una cosa è certa, in quello stato di abbandono che favorisce le profezie, ho potuto vedere l’opera molto simile a come è adesso che l’ho realizzata. Prima era senza luogo né tempo né sostanza, forse è per questo che si è insinuata tanto saldamente nel mio spirito, senza le pastoie delle cose materiali tutte comprese nella loro solidità. In uno di quei frangenti, quando l’ispirazione è più pura, ho visto una fiumana di persone, tre lunghe file interminabili di esseri umani, che mi voltavano le spalle, procedendo indisturbati nel loro cammino, mentre si trasformavano in altrettante fette di pane. Adesso che ho davanti agli occhi l’opera compiuta mi sembra di aver tenuto fede alla mia visione: quelle fette di pane tagliate spesse, sono per me davvero significative, sono come uomini che fanno parte di una sinuosa pagnotta mondo; forse in esse è sotteso l’auspicio che il mondo diventi buono come il pane? Chissà… Senza più carestie, senza fame. Quelle fette di pane accorpate alla tavola imbandita per me rappresentano un inequivocabile messaggio di uguaglianza e fratellanza reso in forma poetica/artistica.
……..zzzzz ……..zzzzz ……..zzzzz
Matteo Peducci

Come fette di pane pesante
Nella descrizione del libro di Gianfranco Bologna, Noi siamo natura, pubblicato per i tipi di Edizioni Ambiente leggiamo:
“Il mondo non morirà per la mancanza di meraviglie, ma per la mancanza di meraviglia”. Questa citazione è generalmente attribuita allo scrittore e giornalista britannico Gilbert Keith Chesterton, ed è perfetta per descrivere ciò che sta accadendo in questo preciso momento storico.“
È vero viviamo nell’epoca degli incontri simultanei e superficiali; un’epoca senza profondità e senza stupore. Ormai a forza di stare connessi a distanza, non sentiamo quasi più il bisogno del contatto e della presenza. Mi viene da pensare ad una scena ripetuta in infinite varianti al cinema e nelle serie tv. In genere vediamo un amante che telefona al suo amore fingendo di trovarsi lontano, mentre in realtà chiama da vicino, spesso da dietro, a pochi passi, lo scherzo si perfeziona al momento dell’abbraccio con la sorpresa che può essere paragonata ad una sorda meraviglia e ad una gioia resa meno intensa dall’abitudine alla distanza. In un gioco di scambi tra lontano e vicino ormai confusi e quasi interscambiabili, dalla nefasta ubiquità indotta dalla tecnologia. Dire che il digitale ha reso presente il lontano non suona più come una metafora, ma come una presa d’atto. L’abbraccio vero ha perso sostanza sostituito dall’incontro attraverso uno schermo. Le relazioni sono diventate meno intense, anche se, almeno in parte, hanno mantenuto la capacità di produrre sorpresa e felicità, implicite in ogni ricongiungimento, fatta salva la naturale necessità di un incontro dal vero, in carne ed ossa.
Lo scadimento dei rapporti interpersonali e la predominanza dell’artificiale sul naturale hanno prodotto un distacco e una diffidenza sempre più manifesta nei confronti della natura e della sua potenza anche sublime . Abbiamo sostituito la presenza con il suo surrogato da schermo, e abbiamo migliorato la realtà con effetti speciali digitali. La velocità dei mezzi di locomozione inoltre, per quanto non riesca a stare al passo con l’ubiquità digitale è riuscita ad adeguarsi, acquistando velocità, al punto che oggi quasi nessuno guarda più fuori dal finestrino perché il paesaggio è una scia indistinta. In passato la vita sempre più frenetica aveva trovato un freno nello slow food, chissà se domani torneranno di moda gli slow trip?
Tanto ormai si percorrono velocemente distanze siderali, e qualcuno addirittura inizia a prenotare viaggi su Marte; la meraviglia è a portata di mano e nessuno si gode più un tramonto o un panorama. La gente va ovunque nel mondo, e i viaggi sono diventati faticosi e superficiali, ma molto alla moda, forse perchè nessuno ha tempo o voglia di guardare fuori dalla finestra di casa sua. Anche per questo la natura viene fotografata, filmata, riprodotta e propagandata in varia guisa, ormai conosciuta troppo e male ha perso tutto il suo mistero.
Fatto sta che il viaggio non è più una forma elevata di conoscenza e di scoperta ma solo la traslazione coatta di masse enormi di persone, da un punto ad un altro del globo. Nessun viaggio è più considerato un rito iniziatico, magari può essere un viaggio della speranza in cui lo sconosciuto e l’inaspettato sono terribili, come spesso accade, per esuli e migranti; in alternativa il viaggio è una vacanza tutto compreso per gente indifferente e distratta, che prova un piacere e uno stupore surrogati, senza veri incontri e senza meraviglia…
E pensando alla meraviglia viene facile pensare ad Aristotele , il quale nel primo libro della Metafisica osservava che:
“Fu per effetto della meraviglia se gli uomini in passato cominciarono a filosofare, come è per questo stesso motivo che continuano a filosofare anche al presente.”
Questa breve proposizione è stata utilizzata come una chiave universale capace di aprire infinite porte, ciò non toglie che la meraviglia cui si riferisce il filosofo non è propriamente quella latina (il termine proviene infatti da mirabilis: cose meravigliose e straordinarie), essa infatti non ha a che fare con le cose. Come ci spiega bene Emanuele Severino in una sua “MIRABILE” lezione: La meraviglia di Aristotele è (il) ”thauma”, e anche se comunemente il termine si traduce con “meraviglia”, esso non somiglia per niente all’accezione latina, perché nel suo significato originario implica "terrore"e"angosciante stupore”.
Dunque se è vero che la meraviglia è il principio del filosofare i sentimenti prodotti dalle cose meravigliose, per diventare strumenti di conoscenza devono essere in grado di produrre nell’uomo non solo piacere ma anche terrore e angosciante stupore.
A partire da questo assunto sarebbe il caso di alzare la posta fino ad affermare che la meraviglia nel suo doppio senso non è soltanto il principio del filosofare ma anche il principio del fare arte, non solo bella ma anche terribile, quale è sempre stata.
Detto questo sarebbe utile che l’uomo contemporaneo in preda ad un coatto distacco dalla realtà tornasse ad immergersi in essa, avventurandosi in quel mondo reale che tornerà così ad essere terribile e meraviglioso insieme; favorendo un incontro con la realtà naturale e con l’altro, fatto di accidenti e di scontri ma anche di seduzione e profondità e bellezza.
In questo senso la pietra è esemplare. L’incontro non sempre necessario con essa qualora avvenga può essere instaurato nel distacco oppure nello scontro ma anche nella seduzione. Forse le prime sculture furono fatte di fango e solo in seguito di pietra, ma lasciamo questo discorso in sospeso e parliamo di marmo (che è pure esso una pietra) e della scultura di Affiliati di Peducci realizzata con questo materiale.
La sua scultura si intitola: La via del pane.
Il fatto che l’artista abbia realizzato un’enorme tavola apparecchiata con sopra numerose fette di pane mi sembra che risponda ad un messaggio elementare e universale insieme. Nell’opera si coniugano l’aspetto estetico (nel senso di artistico) in forte contatto con le tecniche e le modalità operative tradizionali operanti su di una materia pulsante e di per se significante; peso e resistenza sono le sue matrici naturali, gli elementi - che ne hanno modificato l’aspetto e la sostanza ormai sedimentati; adesso tocca all’artista snaturarli e indirizzarli ai suoi fini mediante gesti e tecniche legate a doppio filo con l’antico e la tradizione, ma non per questo meno contemporanei. Poi grazie all’immaginazione l’opera acquisterà la sua magia capace di rendere leggero il pesante e morbido il duro, nell’immobilità.
In quest’opera il valore simbolico della tavola imbandita con il pane, con i suoi richiami umanitari alla carità si eleva sopra le singole fedi religiose; in un messaggio apodittico di fratellanza universale che prelude al superamento della fame e delle disparità. Tutto ciò attraverso una persistenza dell’arte tradizionale per mezzo della quale decide con un gesto quasi anacronistico di affrontare la caparbia durezza della pietra, una materia pesante e refrattaria, difficile da gestire ma capace di restituire la potenza dell’intenzione di colui che la affronta per mutarla, con forza ma anche con rispetto.
Da queste premesse verrebbe spontaneo immaginare uno slogan non retorico che recita: "pane per tutti" ma anche "arte per tutti"; consapevoli che il messaggio implicito nel lavoro passa in secondo piano di fronte alla forza poetica dell’arte, che è sempre capace di produrre non solo consapevolezza ma anche una meraviglia che travalica parole e concetti. Quella meraviglia alimenta l’arte più della filosofia, mentre cerca di dare senso al nostro stare al mondo.
La meraviglia dunque come thauma ispira l’arte e ne diventa il frutto dell’arte, in un circolo virtuoso. Dovremmo riflettere sui motivi per cui uno scultore ancora oggi senta la necessità di confrontarsi con una materia antica e potente come la pietra, dato che avrebbe mille altri modi per comunicare e fare arte e e scatenare emozioni troppo a lungo anestetizzate, per produrre vera meraviglia.
Comprenderemo che pietra e uomo vedono formarsi nell’antitesi il loro indissolubile legame, per questo usando la pietra lo scultore può alimentare il suo legame con la terra e le sue profondità da cui scaturiscono le meraviglie che sempre tengono insieme le gli opposti: la pietra all’uomo e la terra al cielo.
Oggi percepire l’arte come fonte di meraviglia non è facile, in quanto implica l’essere sedotti, non soltanto da una possibile bellezza fonte di stupore, ma soprattutto da quella meraviglia ispirata dal "terrore e dell’angosciante stupore" che sono parte integrante della nostra esperienza e dunque della nostra esistenza.
Un’opera come questa non è pacificante e non deve esserlo, perché l’arte di per se non è soltanto un oggetto di contemplazione, ma un terreno di scontro in cui si forma la conoscenza. Tutte quelle fette di pane pesante e leggero sono pietra, frutto di una stratificazione di terra in quanto materia e di tempo. Prima dell’uomo sulla pietra ha agito la natura, a suo modo artisticamente. È la capacità di mutazione della materia da parte dell’uomo che ci colpisce, quando lo scultore con intenzione modifica una forma, creandone una nuova, magicamente restituisce allo spettatore un’illusione che porta dentro di se il germe della meraviglia. Questo è il monito profondo dell’arte: essa ci insegna a meravigliarci, ci fa comprendere sia la realtà dell’illusione che l’illusione della realtà, sia quella percepita nei sogni, che negli incubi, tanto che nel continuo ricostituirsi di queste polarità l’arte trova la forza di cambiare il mondo.
Paolo Nardon